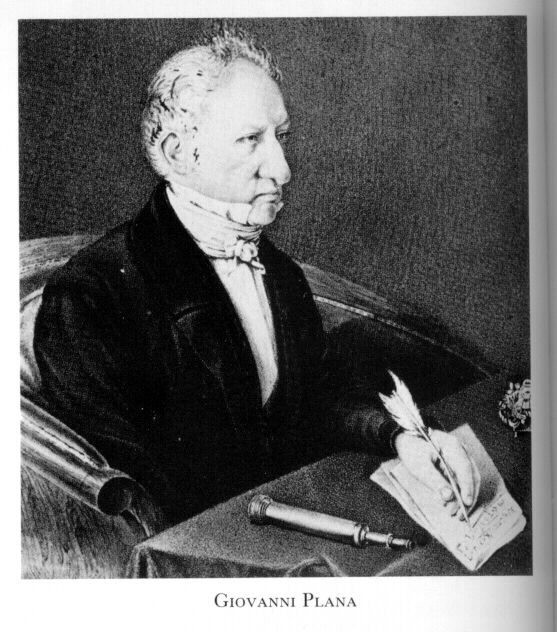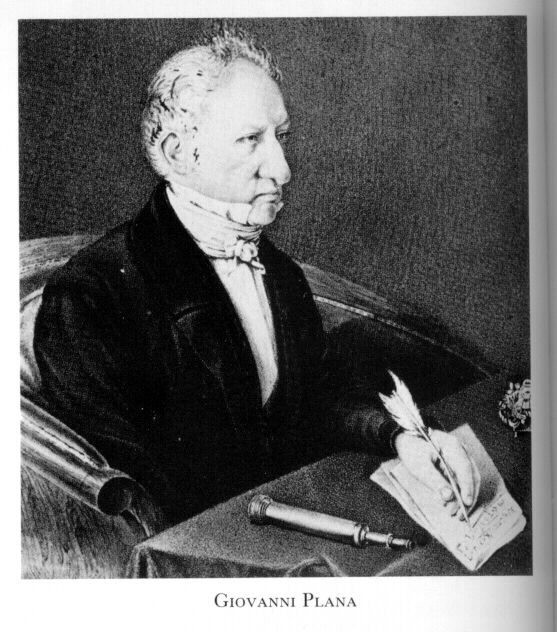Giovanni PLANA
(1781-1864)
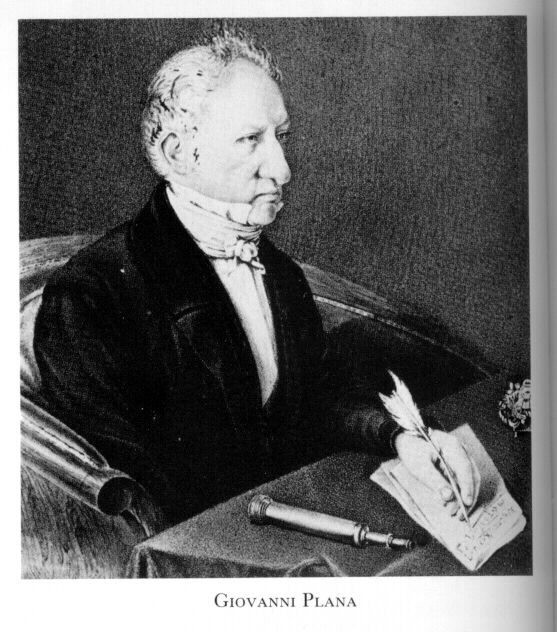
Nacque a Voghera (Pavia) da famiglia d'origine piemontese, l'8 - 11 - 1781 e morì a Torino il 20 - 1 - 1864.
Dal 1800 studiò all'Ecole Polyt. di Parigi ove ebbe, fra gli altri, come maestro L. Lagrange, di cui fu l'unico allievo italiano e di cui, più tardi, sposò una nipote. Rientrato in Italia, nel 1803 divenne professore alla Scuola d'artiglieria d'Alessandria e nel 1811, per suggerimento di Lagrange, fu nominato professore di Astronomia all'Università di Torino, in cui successivamente insegnò pure l'Analisi. Fu il vero fondatore dell'Osservatorio astronomico di Torino che, prima di lui, era solo un modesto annesso della cattedra d'Astronomia. Nella restaurazione sabauda e dopo i moti del 1821 non ebbe noie, anzi fu, più tardi, fatto barone e nominato membro del 1o Senato subalpino (1848).
Membro dell'Accademia delle Scienze di Torino dal 1811, suo vice presidente dal 1842 al '51 e presidente dal 1851 alla morte, ebbe larghi onori anche esteri, fra l'altro, una medaglia d'oro della R. Astronomical Society di Londra. Ebbe però fama di uomo orgoglioso e superbo ed è rimasta tristamente celebre la sua frase al giovane Schiaparelli: Di astronomi ve n'è uno in Piemonte e basta!. Coerentemente non formò alcun allievo.
Fino all'incirca al 1823 il P. fece attive osservazioni astronomiche, soprattutto di astronomia geodetica anche in collaborazione col Carlini di Milano. Poi si occupò quasi soltanto di questioni teoriche, di analisi, di Fisica matematica e, soprattutto, di meccanica celeste.
La sua fama è specialmente legata ai tre grossi volumi sulla Teoria della Luna che, cominciati in collaborazione col Carlini nel 1813, dopo un violento conflitto con questi, fu portata a termine dal solo Plana nel 1832. In essa si riesce - sulla base della sola legge di Newton - a dare una spiegazione sufficientemente precisa dell'intricato movimento del nostro satellite, fondandosi sulla quale possono calcolarsi delle effemeridi abbastanza precise di esso. Fu però osservato che i calcoli sono svolti in modo piuttosto pedestre, e che la monumentalità dell'opera dipende anche dal fatto che il P. non seppe avvalersi di tutte quelle semplificazioni, che già nello stato in cui si trovava la scienza ai suoi tempi, sarebbero state possibili.
Sul palazzo dell'Accademia delle Scienze di Torino una lapide ricorda che ivi il P. portò a termine la sua teoria della Luna e, nell'interno, vi è un busto dell'autore.
Una strada e una scuola di Torino sono a lui intitolate.
Bull. Boncompagni 19, 121-128 (S. Realis); Riv. Municipale Torino, ag. 1935 (L. Volta); ecc.